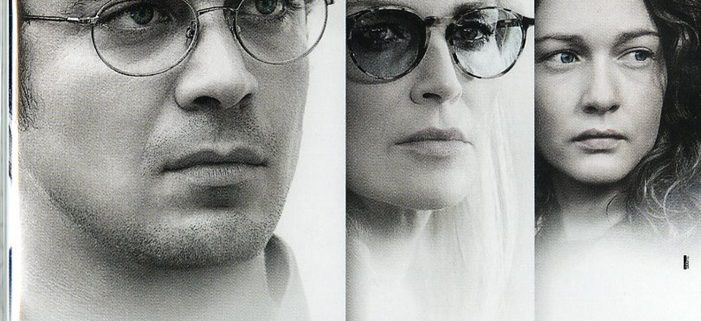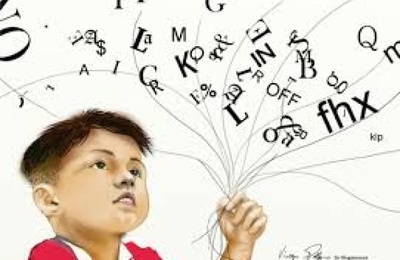VII e VIII incontro del corso di Psicologia dell’Uni3 di Osimo, 20 febbraio – 6 marzo 2017
Durante questi due incontri è stato proiettato il film “Un ragazzo d’oro” di Pupi Avati, con Riccardo Scamarcio e Stefania Capotondi.
Durante la fase di elaborazione, che ha seguito la visione del film, la discussione si è sviluppata intorno ai seguenti argomenti:
- Conflittualità nel rapporto padre figlio, basato su credenze che comportano una distorsione della realtà
- Rapporto di coppia utilizzato come strumento per risarcire un passato doloroso e inaccettabile
- Riscoperta della figura genitoriale e ruolo salvifico del figlio
- Significato del sintomo, come strumento per salvaguardare e proteggere le relazioni affettive significative.
L’analisi delle dinamiche che emergono nel film, ha permesso di affrontare argomenti come il rapporto genitori-figli, ed il ruolo che ognuno ricopre all’interno delle relazioni famigliari.
Lo sviluppo di alcuni concetti ha semplificato l’introduzione dell’argomento che verrà affrontato nella prossima lezione: “Il mito famigliare”.